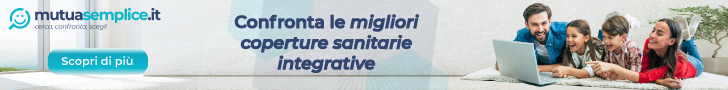Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.
Disturbi dell’umore negli adolescenti: la ricerca di Trento punta alla diagnosi precoce

La parola ad Alessandro Grecucci, docente di Neuroscienze affettive e cliniche
I disturbi dell’umore, della personalità e i disturbi d’ansia possono influenzare profondamente le relazioni sociali e interpersonali, specialmente quando si manifestano nel corso dell’adolescenza, fase in cui insorgono. Individuarli precocemente e intervenire con terapie mirate può ridurre nettamente il loro impatto sullo sviluppo e sul futuro dei giovani oggi sempre più caratterizzati da una fragilità emotiva che condiziona scelte, percorsi da intraprendere e, appunto, l’affermarsi della personalità. È proprio questo l’obiettivo di una serie di ricerche, tra cui uno studio pubblicato ad aprile sulla rivista ‘NeuroImage’, coordinato da Alessandro Grecucci, professore di Neuroscienze affettive e cliniche presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento. Il lavoro, condotto da un team internazionale di neuroscienziati e radiologi provenienti da Italia, Cina e Stati Uniti, si basa su un campione di adolescenti con disturbo bipolare di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Come spiega ad Health il professore Grecucci “l’originalità dello studio sta anche nel fatto che, fino ad oggi, la maggior parte delle ricerche si è concentrata sull’età adulta o ha utilizzato metodi di analisi con diversi limiti”.
Professore, in che modo si manifestano questi disturbi e quale può essere il condizionamento legato al contesto sociale e familiare del paziente?
nostri studi condotti al Cli.A.N. Lab – Clinical and Affective Neuroscience Lab – dell’Università di Trento, mostrano che già in età adolescenziale si osservano alterazioni significative nei circuiti cerebrali coinvolti nella regolazione emotiva, nell’autocontrollo e nella percezione del sé. Nel caso dei disturbi dell’umore come il disturbo bipolare pediatrico, queste alterazioni si manifestano attraverso sbalzi d’umore intensi, irritabilità, impulsività e comportamenti a rischio. Le reti neurali implicate sono quelle fronto-limbiche, che nei nostri risultati mostrano iperattività o disconnessione. Il contesto sociale e familiare gioca un ruolo cruciale: la qualità dell’attaccamento, la presenza di eventi stressanti precoci, il clima emotivo familiare e le esperienze relazionali possono modulare, e in alcuni casi peggiorare, la traiettoria di questi disturbi. Il cervello adolescenziale è particolarmente plastico e vulnerabile a influenze ambientali, motivo per cui è fondamentale intervenire precocemente.
A questo proposito, risulta indispensabile riuscire a intercettare in tempo questi disturbi dell’umore. Qual è l’iter da seguire e a chi devono affidarsi le famiglie per una pronta presa in carico?
La diagnosi precoce è fondamentale per modificare il decorso della malattia. Il primo passo è l’osservazione attenta di segnali comportamentali da parte di genitori, insegnanti e pediatri: cambiamenti drastici nel sonno, nell’umore, nel rendimento scolastico o nella socialità non vanno ignorati. Le famiglie dovrebbero rivolgersi a servizi di neuropsichiatria infantile o psicologia clinica, preferibilmente presso centri universitari o ospedali pediatrici che utilizzino approcci integrati e basati su evidenze neuroscientifiche. Una valutazione completa include colloqui clinici, osservazione del comportamento, scale diagnostiche e, in alcuni casi, neuroimaging e analisi dei pattern cerebrali. Il nostro approccio si basa su metodologie multimodali di imaging e machine learning per identificare biomarcatori precoci e migliorare la precisione diagnostica.

Alessandro Grecucci
Dal 2020 la salute mentale è tornata al centro del dibattito pubblico, anche a seguito della pandemia da Covid-19. Ma qual è il rapporto tra gli italiani e il benessere emotivo?
Il Covid-19 ha avuto un impatto drammatico sulla salute mentale, in particolare tra i giovani. Tuttavia, ha anche aperto una finestra importante: ha reso la salute emotiva un tema meno stigmatizzato. Nonostante questo progresso, in Italia esiste ancora una certa reticenza culturale nel riconoscere il disagio psichico come un problema da affrontare con professionisti. Il nostro paese tende a trascurare il ruolo preventivo e psicoeducativo della psicologia, intervenendo solo nei casi più gravi. È necessario un cambio di paradigma: la salute mentale non è un lusso, ma una componente fondamentale del benessere globale e va integrata nei percorsi educativi, sanitari e lavorativi.
In età adulta è possibile prevenire? In caso contrario, in cosa differisce l’iter da seguire per coloro che, superata l’adolescenza, si ritrovano a dover fare i conti con la propria salute mentale?
La prevenzione in età adulta è possibile, ma è più complessa. Mentre in adolescenza si può ancora agire su meccanismi neurali in fase di sviluppo, in età adulta l’intervento è più focalizzato sulla ristrutturazione di abitudini disfunzionali e sull’apprendimento di strategie di regolazione emotiva. Tuttavia, recenti studi, inclusi i nostri, mostrano che anche in età adulta è possibile modificare circuiti cerebrali attraverso la psicoterapia, l’allenamento cognitivo e, nei casi più gravi, con interventi farmacologici o neurostimolazione. L’iter per l’adulto parte spesso da un medico di base, ma dovrebbe includere figure specializzate: psichiatri, psicologi clinici e psicoterapeuti. È fondamentale promuovere un approccio integrato, centrato sulla persona e aggiornato ai progressi della neuroscienza.
Da quale paese l’Italia può apprendere il giusto metodo di studio e scientifico per trattare e affrontare efficacemente questa branca della medicina?
Ci sono diversi modelli virtuosi. La Germania ha investito moltissimo nella prevenzione psichiatrica giovanile. Il Canada e i Paesi Bassi offrono modelli di salute mentale integrata in cui la figura dello psicologo è presente nei centri di salute pubblica e nelle scuole. Gli Stati Uniti, pur con un sistema diseguale, hanno prodotto molte innovazioni scientifiche grazie all’integrazione tra ricerca di base e clinica. Ma è soprattutto da alcuni centri europei come quelli di Zurigo e Leipzig che possiamo apprendere l’approccio neuroscientifico e computazionale più avanzato: lì la psichiatria non è più solo clinica, ma anche data-driven, fondata sull’identificazione di pattern cerebrali attraverso machine learning, come stiamo facendo anche nel nostro laboratorio.

Per saperne di più sullo studio pubblicato su NeuroImage: http://www.alessandrogrecucci.it/clian-lab/ e https://r.unitn.it/en/dipsco/clian.